Desinenze primarie dell’ottativo dei verbi in ω

Nel panorama della morfologia verbale del greco antico, l’ottativo (ὀπτικόν, optativum) è un modo che esprime desiderio, possibilità, eventualità lontana, condizionale ipotetico. Viene adoperato anche per una maggiore delicatezza semantica e raffinatezza formale.
Non essendo un tempo, ma, come esplicitato poc’anzi, un modo può apparire nel presente, nell’aoristo, nel perfetto, ecc. Qui ci concentriamo sulle forme tematiche (verbi in -ω) e sulle desinenze caratteristiche dell’ottativo.
Nel lessico grammaticale spesso si parla di desinenze primarie (cioè quelle caratteristiche del sistema presente/futuro) e desinenze secondarie (quelle dell’aoristo/imperfetto). L’ottativo ha specifiche desinenze sue; per i verbi tematici distinguiamo soprattutto:
- ottativo presente (o ottativo del sistema tematico): formato con il suffisso ottativo -οι- + le desinenze personali ottative;
- ottativo aoristo: formato con -αι- + desinenze personali ottative (simile per struttura ma con vocale ottativa diversa).
Nella pratica scolastica si presentano spesso due famiglie: ottativo del presente, e ottativo dell’aoristo. All’interno di quest’articolo ci occuperemo soprattutto del present optative dei verbi in -ω e delle loro desinenze personali (quelle che l’utente ha chiamato “primarie”).
Le desinenze primarie dell’ottativo attivo
Le desinenze attive dell’ottativo presente nei verbi in -ω, come riportato dal libro Il nuovo greco di Campanini, risultano eleganti e regolari. Esse sono:
- -οιμι (1ª singolare)
- -οις (2ª singolare)
- -οι (3ª singolare)
- –οιτον (2ª duale)
- -οιτην (3ª duale)
- -οιμεν (1ª plurale)
- -οιτε (2ª plurale)
- -οιεν (3ª plurale)
Nota: la 2ª persona singolare, oscillante tra –οιο e -ου, testimonia due tendenze opposte: una più antica e analitica (ionico-attica), l’altra più contratta e tendenzialmente ellenistica.
Accento e ritmo delle forme ottative
L’accentazione dell’ottativo segue le regole generali della prosodia greca, ma offre una curiosa particolarità: la tendenza della forma a privilegiare un andamento recessivo, con accento che spesso risale verso la radice del verbo.
La presenza del dittongo οι nella sillaba finale, lungo per natura, influisce sulla collocazione dell’accento e contribuisce alla “cadenza sospesa” che caratterizza questo modo.
L’ottativo nel sistema verbale e nella sintassi
Nella prosa attica l’ottativo appare:
- nel discorso indiretto, quando la reggente è al passato:
ἔλεγον ὅτι λύοι (“dicevano che avrebbe potuto sciogliere”); - nella potenzialità remota, spesso con ἄν:
λύοι ἄν (“potrebbe forse sciogliere”); - nel desiderio cortese, tipicamente introdotto da particelle quali εἴθε o εἰ γάρ:
εἴθε λύοιμι (“magari potessi sciogliere”).
Nel periodo ipotetico, l’ottativo compare nelle protasi più distanti dalla realtà, legate a condizioni quasi irreali o immaginate.
Origine indoeuropea del suffisso -οι-
L’ottativo greco, come riportato da A. Meillet nell’“Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes”, deriva da un’antica formazione indoeuropea marcata da un suffisso vocalico formato da -yē/-ih₁-, che in greco ha subito una serie di trasformazioni fonetiche fino a stabilizzarsi nel dittongo -οι-.
- In proto-indoeuropeo, l’ottativo aveva valore desiderativo o potenziale, attestato per esempio:
- nel sanscrito (optativo in -yā-, -īyā- → bhavāyām, “possa essere”)
- nell’antico iranico (ahyā, dāyā)
- in forme isolate dell’antico slavo ecclesiastico e del baltico.
Il greco è una delle lingue indoeuropee in cui il sistema ottativo è rimasto più produttivo e morfologicamente coerente.
Come nasce il -οι- greco?
Il passaggio ricostruito è il seguente:
- Suffisso indoeuropeo -yē- / -ih₁-
- Palatalizzazione e dittongazione → -yoi-
- Stabilizzazione attica → -οι-
Questa evoluzione spiega perché il dittongo οι sia percepito come intrinsecamente lungo, e dunque influenzi l’accentazione delle forme ottative.
L’evoluzione e declino dell’ottativo nella lingua greca
1 Età micenea e arcaica
Nel miceneo, l’ottativo esiste, ma è scarsamente attestato nelle tavolette in lineare B. Lo ritroviamo invece pienamente funzionante nell’Odissea e nell’Iliade, dove:
- esprime frequentemente desideri e preghiere;
- si combina con particelle come κέ o κε (valore potenziale);
- presenta maggiore libertà fonetica, con alternanze come -οιη/-οιμι, più poetiche.
2 Greco classico
Nell’attico l’ottativo diventa:
- uno strumento sintattico essenziale nel discorso indiretto al passato (regola del backshifting);
- un marcatore di cortesia e desiderio;
- la forma del “potenziale” remota con ἄν.
Le forme duali sono rare nella prosa classica (tranne Erodoto), ma perfettamente funzionanti in poesia.
3 Età ellenistica
In questo periodo si assiste al declino progressivo dell’ottativo:
- il modo è sempre meno usato;
- viene spesso sostituito dal congiuntivo con particelle modali;
- nelle lingue della koiné (soprattutto nei Vangeli) quasi scompare.
Le forme duali diventano puramente letterarie.
4 Greco tardo e bizantino
L’ottativo sopravvive solo in:
- formule fisse;
- citazioni classiche;
- testi poetici.
È completamente sostituito da nuove perifrasi modali, in particolare con θέλω + infinito.

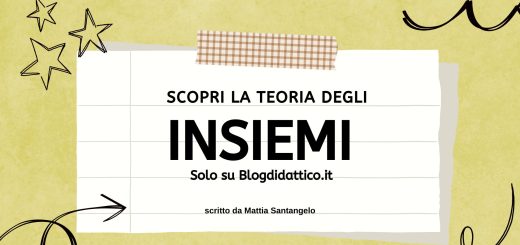
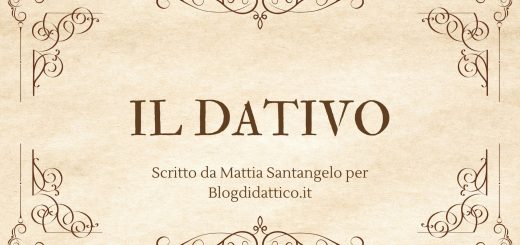
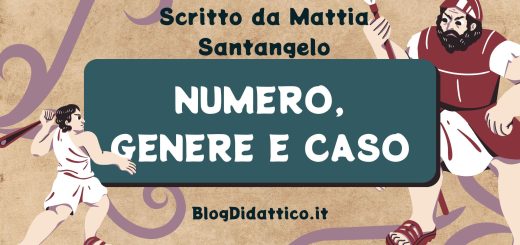
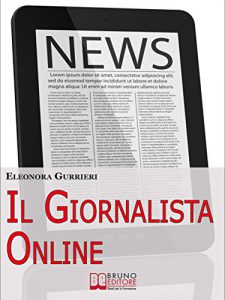
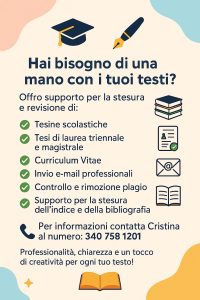


2 Risposte
[…] i verbi più rappresentativi della morfologia greca vi è λύω, paradigma canonico dei verbi in -ω, […]
[…] Per comprenderlo appieno, è utile concentrarsi su un paradigma concreto: λύω, “sciogliere”, paradigma regolare dei verbi in -ω. […]