Gli elementi costitutivi del verbo
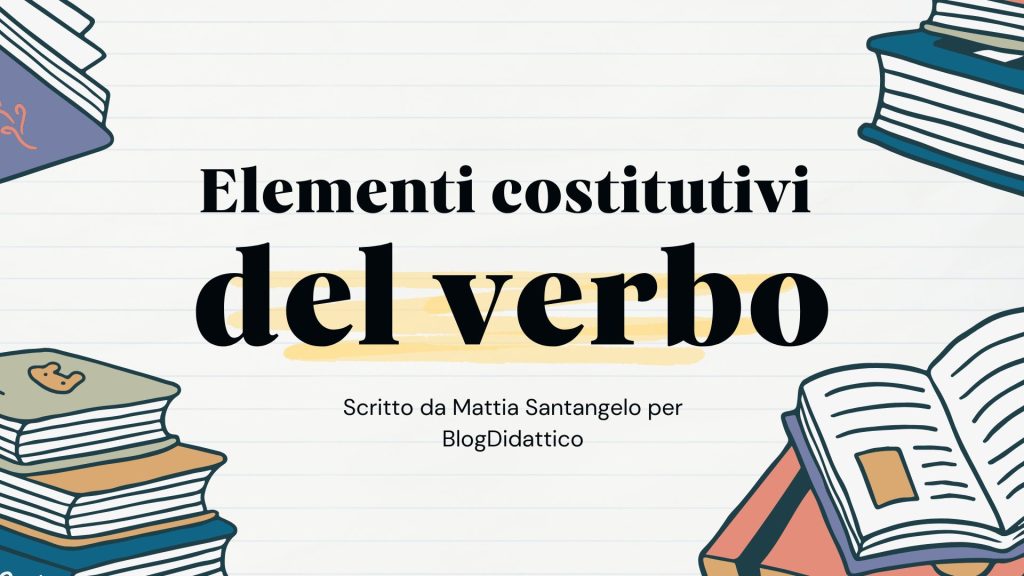
Il verbo del greco antico rappresenta uno degli aspetti più complessi e affascinanti della lingua. Esso, come abbiamo già analizzato negli articoli precedenti all’interno del nostro blog, concentra in sé numerose informazioni grammaticali, condensate in una sola forma: persona, numero, tempo, modo, diatesi e tema verbale. Per padroneggiarlo, è necessario comprendere a fondo i suoi elementi costitutivi, cioè le parti che contribuiscono alla formazione e al significato di ogni voce verbale.
Il tema verbale
Alla base di ogni forma verbale possiamo riconoscere il tema, ossia la parte che rimane immutata in tutta la coniugazione ed esprime il significato fondamentale del verbo. Ogni tempo presenta un suo specifico tema, della cui formazione ci occuperemo in modo approfondito negli articoli venturi che ti invito a non perdere.
Ecco i vari temi:
- Tema del presente (es. λυ- in λύω, “sciolgo”);
- Tema del futuro (es. λυσ- in λύσω, “scioglierò”);
- Tema dell’aoristo (es. λυσ- in ἔλυσα, “sciolsi”);
- Tema del perfetto (es. λελυκ- in λέλυκα, “ho sciolto”).
Questa molteplicità è detta suppletivismo dei temi verbali, ed è una delle caratteristiche principali del sistema verbale greco.
La vocale tematica
Uno degli elementi più importanti è la vocale tematica, tipica dei verbi in -ω (i cosiddetti tematici). Essa è:
- ο/ε alternante (fenomeno di apofonia): λύ-ο-μεν, λύ-ε-τε;
- assente nei verbi atematici (o in -μι), che si costruiscono direttamente sul tema (es. δίδωμι, “dò”).
La vocale tematica svolge la funzione di legame tra radice e desinenze.
Se ti possa interessare un articolo maggiormente approfondito sui verbi in -ω e in -μι, ti consiglio di consultare il post precedente a questo. Inoltre, se hai degli amici, parenti o semplici conoscenti che si interessano alle nozioni del greco antico puoi anche pubblicare quest’articolo sul tuo social preferito, come Facebook, Instagram o X.
La desinenza
Dopo la vocale tematica nei verbi in -ω , direttamente dopo il tema verbale nei verbi in -μι si trovano le desinenze, che veicolano le seguenti informazioni grammaticali:
- la persona (prima, seconda, terza);
- il numero (singolare, duale, plurale);
- il modo (indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo);
- il tempo (presente, futuro, aoristo, perfetto, piuccheperfetto).
Esse si suddividono in:
- desinenze primarie, proprie dei tempi principali;
- desinenze secondarie, proprie dei tempi storici.
Ognuno di questi due sottogruppi si suddivide a sua volta in quattro serie:
- desinenze attive;
- desinenze medio-passive;
- desinenze medie;
- desinenze passive.
Una serie a parte è rappresentata dalle desinenze dell’imperativo, anch’esse divise in attive e medio-passive.
La terminazione
Dicesi terminazione o uscita l’insieme di vocale tematica e desinenza. Tale denominazione viene necessariamente usata nei casi in cui una vocale tematica e desinenza si sono fuse tra loro, così da non poter essere distinte l’una dall’altra.
Esempio: λύ-ο–μεν “noi sciogliamo”. La terminazione ομεν è formata appunto dalla vocale tematica -ο- e dalla desinenza -μεν.
L’aumento
Per indicare i tempi storici all’indicativo (imperfetto, aoristo, piuccheperfetto), il verbo greco utilizza l’aumento, un prefisso che si aggiunge al tema:
- aumento sillabico: ε- davanti a tema che inizia per consonante (es. λύω → ἔλυον);
- aumento temporale: allungamento della vocale iniziale del tema (es. ἀκούω → ἤκουον).
L’aumento non è un elemento originario della lingua indoeuropea, ma una caratteristica propria del greco.
Il raddoppiamento
Caratteristica del perfetto e del piuccheperfetto è la raddoppiamento, ossia la ripetizione dell’iniziale del tema con una vocale ε:
- λύω → λέλυκα (“ho sciolto”);
- γράφω → γέγραφα (“ho scritto”).
Se il tema inizia per vocale, il raddoppiamento consiste nell’allungamento di tale vocale (es. ἀκούω → ἀκήκοα).
I suffissi temporali e modali
Alcuni tempi si formano con suffissi che si interpongono tra tema e desinenza:
- suffisso -σ- per il futuro e l’aoristo sigmatico (λύσω, ἔλυσα);
- suffisso -κ- per il perfetto (λέλυκα);
- suffissi particolari per l’ottativo (-οι-, -ει-, -αι-).
Questi suffissi sono essenziali per distinguere i valori temporali e modali.


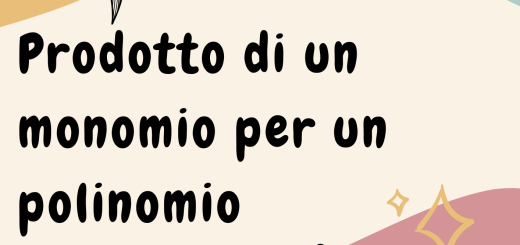
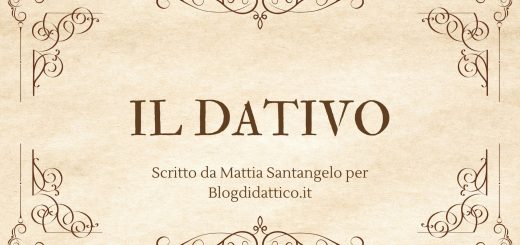
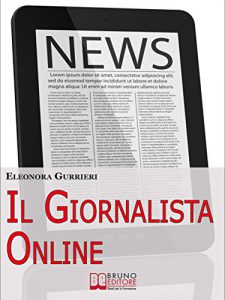
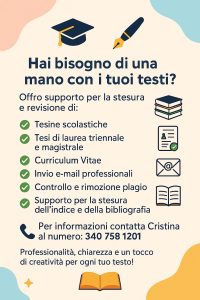


Una risposta
[…] -ειν, derivante dalla contrazione della desinenza -εν con la vocale tematica -ε-. sssendo un verbo impersonale, sarà pertanto costituito solo da quell’unica […]