Coniugazione dell’indicativo presente e dell’infinito medio-passivo di Λύω
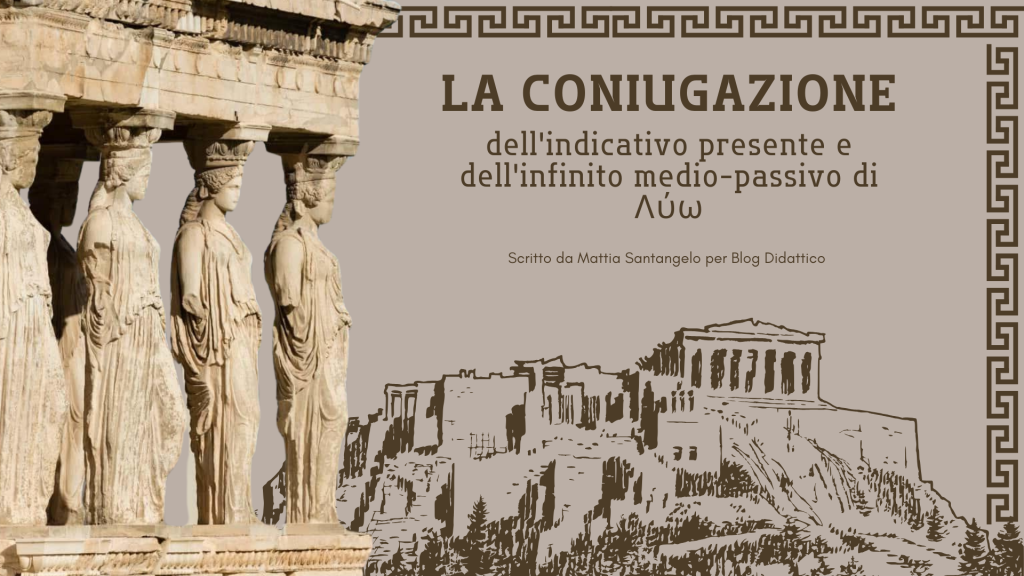
Quando si comincia a studiare greco antico, c’è un verbo che ritorna dappertutto: λύω. Tutti lo conoscono, tutti lo coniugano, tutti lo usano. È il verbo “io sciolgo”, e non è solo un esercizio scolastico: è un piccolo monumento linguistico.
Perché proprio lui? Perché λύω è il modello perfetto del verbo greco, quello che i grammatici usavano già nell’antichità per spiegare ai ragazzi come funzionava il sistema verbale.
È un verbo tematico, cioè la radice verbale (λυ-) si lega tramite una vocale tematica (ο/ε) alle desinenze della coniugazione.
Nel medio-passivo il significato cambia:
- medio → azione compiuta a vantaggio del soggetto (“sciolgo per me”, “mi sciolgo”)
- passivo → soggetto che subisce l’azione (“sono sciolto”, “vengo sciolto”)
Nel presente, le due diatesi (media e passiva) hanno le stesse forme, e sarà il contesto a chiarire se il valore è medio o passivo.
All’interno di quest’articolo riporteremo curiosità e informazioni che ci permetteranno di scoprire come anche un semplice io sono sciolto possa nascondere meraviglie filologiche.
Medio-passivo: una diatesi presente nel greco, ma sconosciuta nell’italiano
Come già esposto all’interno del nostro blog, il medio è una diatesi che possiamo ritrovare solo nell’antico greco, in quanto poi è andata perduta. Nell’italiano di oggi, infatti, restano vive solo la diatesi attiva e passiva. Eppure, però, nelle fasi più antiche della lingua (greco miceneo e indoeuropeo), il sistema verbale aveva solo due diatesi: attiva e medio-passiva. Il passivo vero e proprio non era una categoria indipendente come nell’italiano moderno. Il medio portava dentro di sé due funzioni:
- Funzione medio-riflessiva: “io faccio qualcosa per me, su di me, nel mio interesse” → λύομαι = mi sciolgo, mi libero.
- Funziona passiva: io subisco l’azione” → λύομαι = sono sciolto.
La separazione tra medio e passivo comincia a emergere più tardi, quando la lingua, specialmente nella prosa del V secolo a.C., sente l’esigenza di rendere più chiaro il rapporto tra chi compie un’azione e chi la subisce. Questa esigenza si manifesta nei tempi narrativi, quelli che raccontano eventi puntuali, precisi, netti. È proprio qui che nascerà il suffisso -θη-, la marca del nuovo passivo greco: prima timido, poi sempre più frequente. La lingua comincia a distinguere due concetti diversi: l’azione che qualcuno fa su se stesso e l’azione che qualcuno subisce. Così ἐλυσάμην significa “mi liberai”, mentre ἐλύθην diventa chiaramente “fui liberato”. È una svolta lenta ma decisiva: il passivo si emancipa dal medio. Ma di questo, ne parleremo solo successivamente.
Perché il passivo non nasce in tutti i tempi?
È molto interessante osservare che il passivo nuovo non si sviluppa uniformemente in tutto il sistema verbale. Rimane confinato soprattutto nell’aoristo e nel futuro, due tempi fortemente orientati all’azione esterna e puntuale. Al contrario, il presente, l’imperfetto e l’intero sistema del perfetto continuano a utilizzare le forme antiche, esattamente come se il passivo autonomo non fosse mai nato. Questa “resistenza” è dovuta all’evoluzione naturale delle lingue: quando un sistema funziona, tende a rimanere invariato. Il presente, per esempio, descrive stati e abitudini, cioè situazioni difficilmente bisognose di una distinzione netta tra medio e passivo.
Coniugazione dell’indicativo presente medio-passivo di Λύω
Singolare
- λύομαι
- λύῃ / λύει
- λύεται
Duale
- λύεσθον
- λυέσθον
Plurale
- λυόμεθα
- λύεσθε
- λύονται
Una delle forme più affascinanti: λύῃ
La seconda persona singolare è una miniera di curiosità.
La forma “ufficiale” attica è λύῃ, ma nei testi si trova spesso anche λύει, soprattutto in Omero e nei dialetti ionici.
Curiosità sulla sua storia
La forma originale era:
λυέσαι
Poi:
- la sigma (σ) tra due vocali cade
- diventa λυεαι
- e infine le vocali si contraggono → λύῃ
Quindi quella iota sottoscritta non è decorativa: è il fossile di un’antica ι.
L’infinito: μικρὸς, ἀλλ᾽ ἰσχυρός
“Piccolo, ma potente”: così potremmo descrivere l’infinito λύεσθαι.
È formato da:
λυ- + ε + σθαι
E ha mille usi diversi. Uno dei più belli è quando regge verbi come:
- βούλομαι λύεσθαι – voglio liberarmi / essere liberato
- δύναμαι λύεσθαι – posso sciogliermi
- νομίζω λύεσθαι – ritengo di essere sciolto
Spesso, l’infinito medio-passivo ha una delicatezza semantica che l’attivo non possiede: sembra più “interno”, più personale.


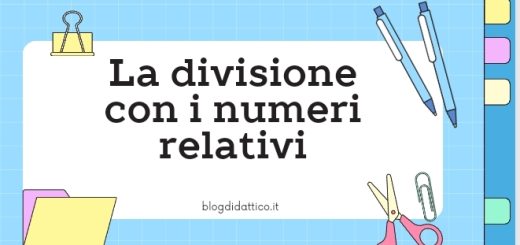
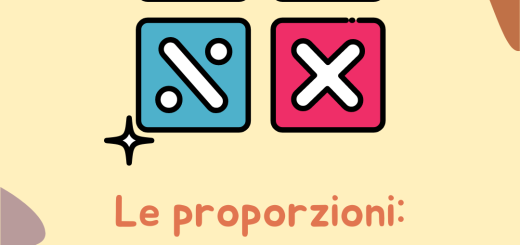
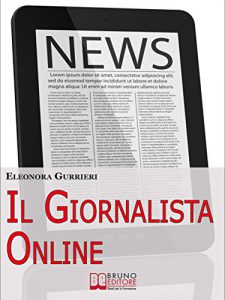
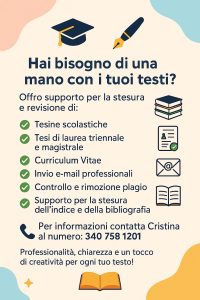


2 Risposte
[…] com’è noto, esprime possibilità, volontà, esortazione o finalità e si distingue dall’indicativo non per le desinenze personali, ma per la vocale modale lunga (ω / η) che sostituisce le vocali […]
[…] verbo λύω (“sciogliere, liberare”), appartenente alla prima coniugazione dei verbi tematici, presenta […]