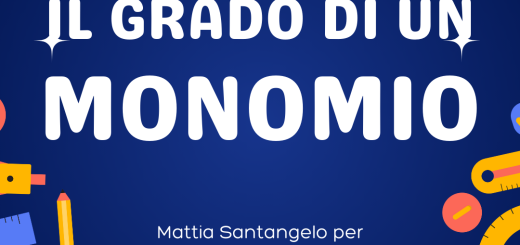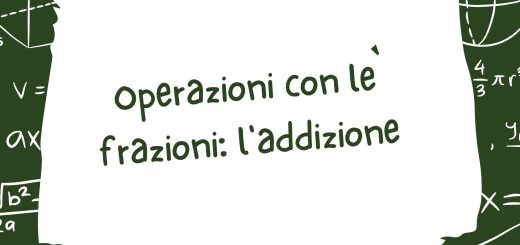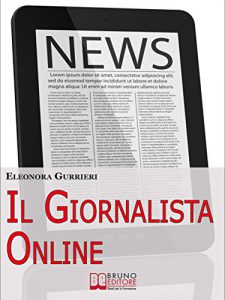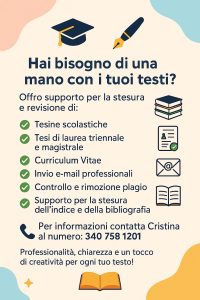Il digamma: la lettera perduta dell’alfabeto greco

L’alfabeto greco ha subito numerose trasformazioni nel corso della storia, e, oltre allo jod già trattato precedentemente, tra le sue lettere dimenticate spicca il digamma (Ϝ, ϝ). Questa lettera, caduta in disuso con il tempo, si collocava tra l’epsilon (Ε, ε) e la zeta (Ζ, ζ) e aveva un’importanza fonetica notevole. Il suo nome deriva dalla sua forma, che richiama due gamma sovrapposti (Γ+Γ), suggerendo una forte connessione con l’evoluzione della scrittura greca. Sebbene oggi non venga più utilizzata, il digamma ha lasciato un’impronta indelebile nella lingua e nella letteratura greca.
Origine e uso
Il digamma trae origine dall’alfabeto fenicio, proprio come le altre lettere greche. Il suo suono corrispondeva a una consonante approssimante labiovelare /w/, simile alla “w” inglese. Era una lettera comune nei dialetti greci arcaici, come il miceneo e l’omerico, e compariva spesso nelle iscrizioni più antiche. Tuttavia, con il tempo, il suono /w/ iniziò a scomparire nella pronuncia e il digamma venne progressivamente eliminato dalla scrittura ufficiale.
Uno degli esempi più chiari del suo utilizzo è nelle forme arcaiche di alcune parole greche. Nel dialetto miceneo e l’omerico, per esempio, la parola per “buono” era wékos, che nel greco classico si trasformò in οἶκος (oíkos, “casa”). Allo stesso modo, la parola wánax (“re”) divenne ἄναξ (ánax), mostrando chiaramente l’effetto della scomparsa del digamma.
Scomparsa del digamma
L’uso del digamma cominciò a declinare attorno al IX-VIII secolo a.C., con differenze significative a seconda della regione. Nei dialetti greci arcaici, come quello di Atene, il digamma sparì molto presto, mentre in altri, come il dorico e l’eolico, rimase più a lungo. Tuttavia, nonostante la sua scomparsa dalla scrittura ufficiale, il digamma lasciò tracce evidenti nella poesia epica e nella metrica greca.
Nell’Iliade e nell’Odissea, per esempio, la presenza originale del digamma spiega alcune anomalie metriche. Poiché il greco antico era una lingua fortemente legata alla prosodia e al ritmo, la scomparsa improvvisa di un suono consonantico come /w/ alterò il modo in cui i versi omerici venivano recitati. Ad esempio, la parola ἦμαρ (hēmar, “giorno”) derivava da un più antico ϝῆμαρ (wēmar), e la sua caduta causava la contrazione di sillabe che in origine avrebbero rispettato un ritmo regolare. Questo fenomeno è osservabile in molte parole della poesia omerica, come οἶκος (oíkos, “casa”), che in passato era ϝοῖκος (woikos), e ἔργον (érgon, “lavoro”), che derivava da ϝέργον (wérgon).
Gli studiosi ritengono anche che i rapsodi, durante le esecuzioni pubbliche delle opere omeriche, dovessero essere consapevoli di questi cambiamenti e adattare la recitazione per preservare il ritmo esametrico. Alcune irregolarità nei versi possono essere spiegate proprio attraverso la ricostruzione delle forme arcaiche delle parole che contenevano il digamma.
Eredità e influenza
Nonostante la sua scomparsa dalla lingua parlata e scritta, il digamma ha lasciato un’importante eredità:
- è l’antenato diretto della lettera F nell’alfabeto latino, che mantiene la sua forma simile;
- è sopravvissuto nel sistema numerico greco con il valore di 6, dove è noto anche come “stigma“;
- il suo studio ha permesso ai linguisti di ricostruire con maggiore precisione l’evoluzione della fonetica greca e il passaggio dai dialetti arcaici a quelli classici.