Sostantivi femminili in alpha puro

I sostantivi femminili in alpha puro costituiscono un gruppo importante della prima declinazione in greco antico. Come già accennato nel precedente articolo riservato ai caratteri generali della prima declinazione, si definiscono in questo modo perché la vocale tematica dell’ultima sillaba (il tema) è un α che rimane invariato in tutti i casi (quindi “puro”).
All’interno di questo articolo riporteremo la declinazione completa e specifiche osservazioni che potrebbero tornarti utili nel corso del tuo studio. Se vuoi saperne sempre di più, inoltre, ti invitiamo a restare costantemente aggiornato al nostro blog e, qualora tu voglia rendere partecipi anche altri delle tue conoscenze acquisite, puoi benissimo pubblicarlo sul tuo social preferito.
Differenze tra alpha puro e alpha impuro
Per comprendere appieno la natura dei sostantivi in alpha puro, è utile fare un confronto con la variante più comune, quella in alpha impuro. In quest’ultima, i sostantivi possiedono una vocale tematica α che tende a mutare in η in certi casi, soprattutto al singolare, come accade nei sostantivi che presentano un tema con consonante labiale o dentale (ad esempio, τιμή, “onore”).
Al contrario, nei sostantivi in alpha puro questo mutamento non avviene mai. L’α resta sempre identica, indipendentemente dal caso o dal numero. Questa caratteristica di “purezza” dell’alpha è ciò che dà il nome a questa classe di sostantivi.
Origine e diffusione dialettale
Dal punto di vista dialettale, i sostantivi in alpha puro sono particolarmente frequenti nei dialetti ionico e dorico, mentre nell’attico spesso troviamo la coesistenza di forme in alpha puro e alpha impuro. Questa differenza rispecchia la ricchezza e la varietà linguistica del greco antico: a seconda della regione e dell’autore, possiamo incontrare sfumature e forme diverse, ma sempre riconoscibili grazie alla struttura regolare dell’alpha puro.
Funzione e uso nei testi antichi
Nella letteratura e nella documentazione epigrafica, i sostantivi in alpha puro ricorrono spesso in contesti descrittivi e narrativi. Ad esempio, θάλασσα si ritrova nei poemi omerici, dove evoca la vastità e la forza del mare, ma anche nei dialoghi filosofici per indicare metaforicamente la mutevolezza o la profondità.
Anche γλῶσσα compare sia come “organo del linguaggio” sia come simbolo di eloquenza e cultura.
Questi sostantivi, quindi, non sono solo forme grammaticali, ma veicoli di significati ricchi e stratificati.
La declinazione
| Numero | Caso | ἑσπέρα (giorno) |
|---|---|---|
| Singolare | Nominativo | ἡ ἑσπέρα |
| Singolare | Genitivo | τῆς ἑσπέρας |
| Singolare | Dativo | τῇ ἑσπέρᾳ |
| Singolare | Accusativo | τὴν ἑσπέραν |
| Singolare | Vocativo | – ἑσπέρα |
| Duale | Casi diretti | τώ ἑσπέρα |
| Duale | Casi obliqui | τοῖν ἑσπέραιν |
| Plurale | Nominativo | αἱ ἑσπέραι |
| Plurale | Genitivo | τῶν ἑσπερῶν |
| Plurale | Dativo | ταῖς ἑσπέραις |
| Plurale | Accusativo | τὰς ἑσπέρας |
| Plurale | Vocativo | – ἑσπέραι |
Elementi fonetici e morfologici
Dal punto di vista fonetico, il mantenimento dell’alpha puro è un tratto che riflette la stabilità morfologica. Non ci sono alterazioni vocaliche significative, il che rende la declinazione di questi sostantivi uno dei modelli più lineari dell’intero sistema nominale greco. Tuttavia ricordiamo:
- l’uscita -αι del nominativo e del vocativo plurale, è considerata breve ai fini dell’accento;
- il genitivo plurale deriva dalla contrazione della vocale finale con la desinenza –ῶν (ἑσπεραῶν = ἑσπερῶν). A livello dell’accento è sempre perispomeno;
- la terminazione dei casi diretti del duale e dell’accusativo plurale è sempre lunga a prescindere dalla quantità originaria della vocale finale del tema;
- rientra nel gruppo dei temi in α puro anche il sostantivo στοά (portico). Il motivo è prettamente etimologico. Infatti, originariamente, era preceduto da uno j (jod) che poi è caduto con il tempo.

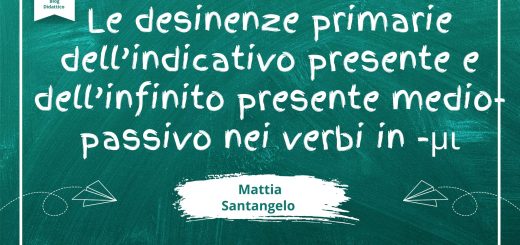
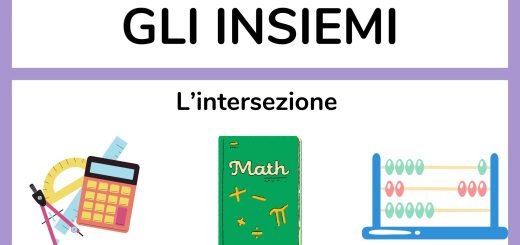

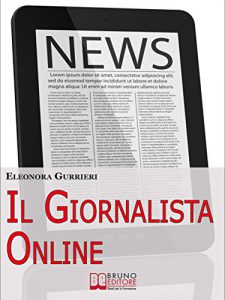
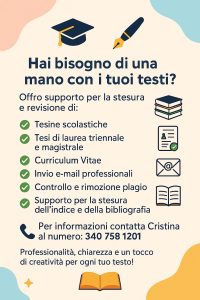


Una risposta
[…] quest’articolo, dopo aver trattato i sostantivi della prima declinazione in alpha puro e impuro nei precedenti articoli, ci focalizzeremo esclusivamente sui caratteri generali dei […]