L’imperativo presente
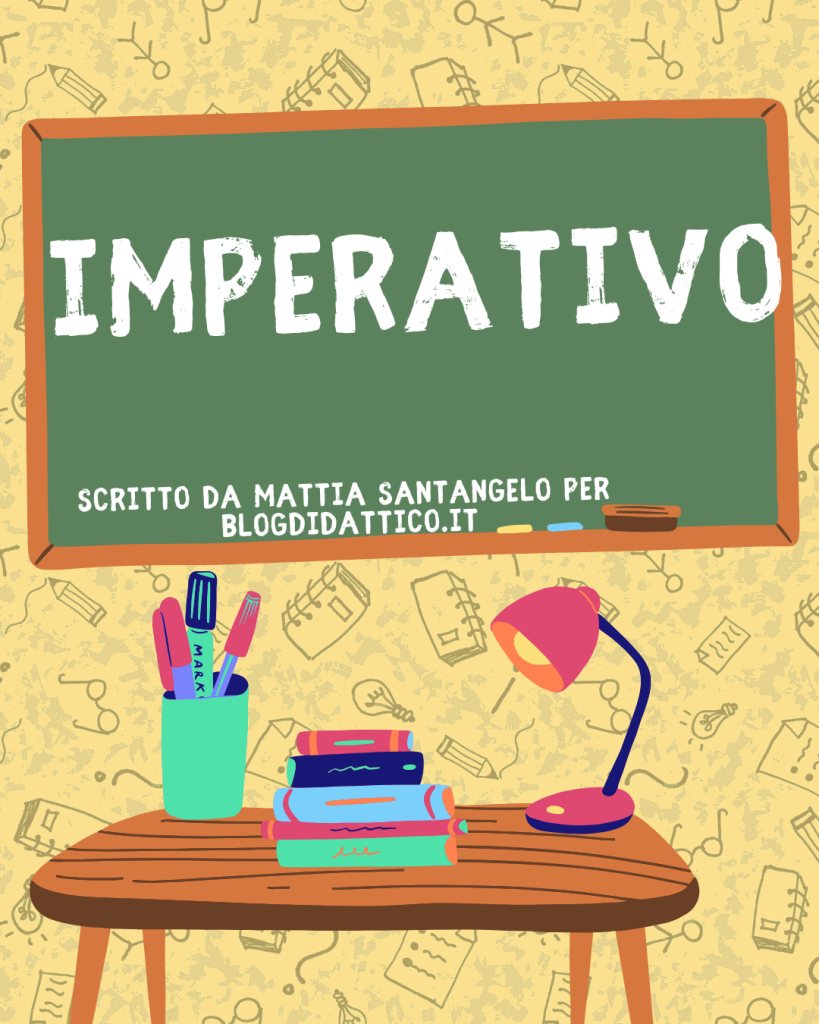
Ti è mai capitato di dare un comando, o quantomeno di riceverlo? Per esempio quando la professoressa ordina di studiare? Oppure ti è mai successo di fare un’esortazione ad un tuo amico, invitandolo a non dimenticare l’invito di quella sera? O ancora non ti è mai accaduto di salutare anche con un semplice “Salve” una persona più grande di te? Io immagino che tutte queste cose ti siano successe almeno una volta. Ma ti sei mai interrogato sulla loro natura grammaticale? Che tempi si usano nello specifico per esprimere tutte quelle cose?
Soltanto i meno attenti non si sono accorti di quanto la nostra amata lingua italiana sia la più variegata e automaticamente la più difficile da imparare per qualcuno che è straniero. Tant’è vero che siamo tra le lingue con più tempi verbali e modi al mondo. Nello specifico, tutti i contesti di prima vengono espressi con l’imperativo. Sì, persino Salve è un imperativo. Eppure usiamo quella parola tutti i giorni per salutare come una forma di rispetto e educazione. Come potrebbe mai esserlo? Ebbene, nuovamente, la risposta proviene dal passato. Devi sapere, caro lettore, che Salve deriva dal latino “salvē“, la seconda persona singolare dell’imperativo presente del verbo salvēre, (star bene, essere in salute), tradotta a sua volta dalla forma greca χαῖρε e χαίρετε, rispettivamente la seconda persona singolare e plurale di χαίρω che vuol dire rallegrarsi.
Quindi, se al giorno d’oggi disponiamo di così tanti tempi e modi verbali, la responsabilità è principalmente delle due lingue che ci hanno preceduto. Nell’articolo di oggi, tuttavia, tratteremo l’imperativo presente del greco antico
Definizione
L’imperativo è il modo verbale che esprime ordine, esortazione, comando o invito.
È tipico della lingua parlata, dei discorsi militari, delle formule rituali e della poesia drammatica.
A differenza dell’italiano, l’imperativo greco ha una struttura più ampia: non si limita al presente e al futuro, ma presenta anche un imperativo nell’aoristo e, raramente, nel perfetto.
Come tutti gli altri modi ha l’attivo e il medio-passivo al presente.
Valori semantici
L’imperativo greco non indica solo comando, ma anche diverse sfumature:
- Ordine diretto:
- Σιγάτω! → “Taccia!”
- Esortazione (più gentile, vicina al nostro “ti prego”):
- Μιμνῄσκεο. → “Ricordati.”
- Permesso o concessione:
- Ἔστω. → “Sia pure / Va bene.”
- Invito alla preghiera o formula solenne (soprattutto nei riti):
- Χαῖρε! → “Salve!”
- Minaccia o legge (uso futuro):
- Θανεῖται. → “Morirà!” (= sia destinato a morire).
Impieghi letterari
- Omero ed epica → frequente uso dell’imperativo futuro come solenne predizione o comando divino.
- Tragedia → usato in invocazioni e maledizioni.
- Prosa attica → molto usato nei dialoghi (soprattutto in Platone) e nelle leggi (es. in Aristotele e nei decreti attici).
Curiosità: la magia dell’imperativo
Alcuni studiosi parlano dell’imperativo come di un “modo magico” del verbo. Perché? È semplice: la sua forza non è nel descrivere, ma nell’agire. Quando in un testo epico o tragico un dio ordina con un imperativo, l’ordine non è solo un suono: è destino. Lo stesso vale per le maledizioni, le benedizioni o i saluti beneaugurali.

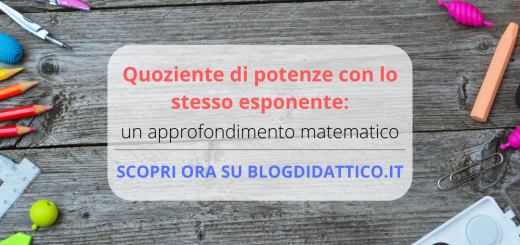
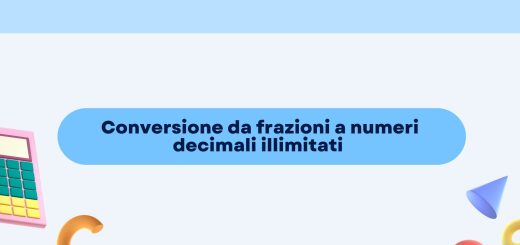

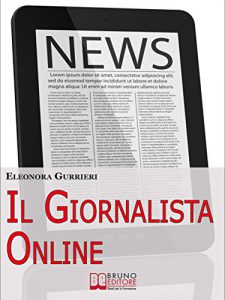
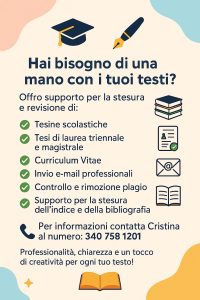


Una risposta
[…] L’imperativo presente medio-passivo dei verbi in -ω del greco antico è una forma verbale fondamentale per esprimere ordini, consigli, inviti e prescrizioni rivolti al soggetto che compie l’azione su sé stesso (diatesi media) oppure la subisce (diatesi passiva). […]