L’aumento nei verbi composti
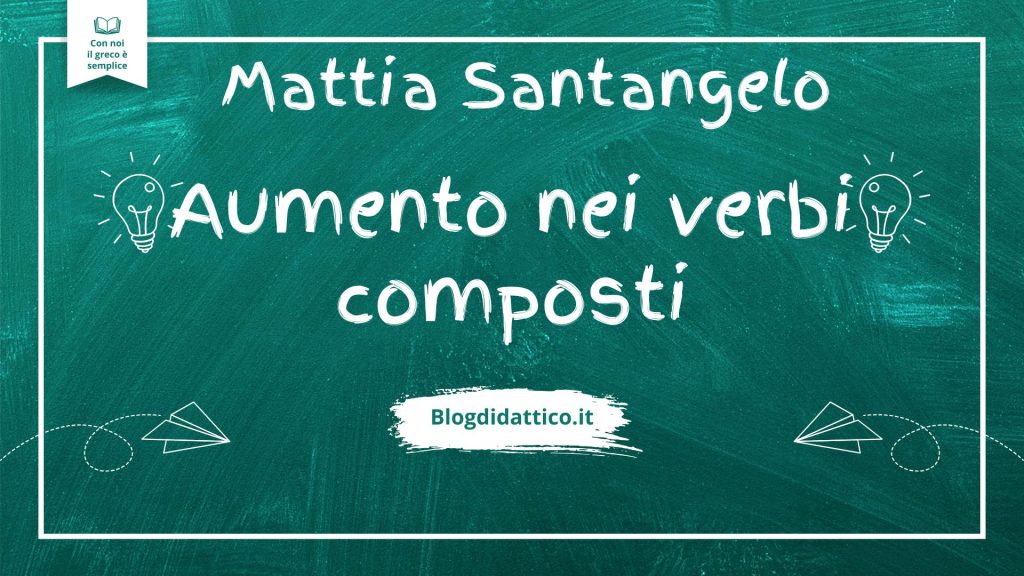
L’aumento, come già accennato nei precedenti articoli, è uno degli elementi morfologici più caratteristici del verbo greco, soprattutto nella formazione dei tempi storici (imperfetto, aoristo e piuccheperfetto). Si tratta di un fenomeno che coinvolge soltanto l’indicativo e che ha una chiara funzione diacronica: serve a marcare la differenza tra il presente e i tempi che indicano un’azione passata. Non è dunque un segno di tempo in senso stretto, ma piuttosto un marchio di passato tipico della lingua indoeuropea, che il greco ha conservato e sviluppato in maniera peculiare.
Il meccanismo dell’aumento si presenta in due forme: l’aumento sillabico (una ε- prefissa davanti a radici che iniziano per consonante) e l’aumento temporale (allungamento della vocale iniziale nel caso di verbi che cominciano con una vocale o un dittongo). Entrambi hanno la funzione di segnalare il tempo storico, ma il loro comportamento non è sempre regolare, soprattutto nei verbi composti con preposizione.
È proprio in questo ambito che sorgono le questioni più complesse: dove va collocato l’aumento quando un verbo è preceduto da uno o più prefissi preposizionali? Davanti a tutto il composto o solo davanti alla radice verbale? Per rispondere, occorre analizzare l’evoluzione storica e le variazioni che la lingua greca conosce nelle sue diverse epoche e nei suoi diversi dialetti.
Il problema dell’aumento nei verbi composti
I verbi composti con preposizione pongono un problema fondamentale: se un verbo semplice come βάλλω diventa προσβάλλω, nel passato indicativo ci si deve chiedere se la forma corretta sia προσέβαλλον (aumento dopo la preposizione) oppure ἐπροσβάλλον (aumento prima della preposizione).
La tradizione grammaticale antica e la pratica degli autori ci mostrano che entrambi gli usi sono attestati, e ciò riflette un lungo processo di evoluzione linguistica. In origine, quando la preposizione era ancora un elemento relativamente indipendente e non completamente fuso con il verbo, l’aumento tendeva a collocarsi prima di tutto il gruppo, quindi davanti alla preposizione: ἐπροσβάλλον. Col tempo però, la fusione tra preposizione e verbo diventò sempre più stretta, e allora prevalse l’uso di collocare l’aumento immediatamente davanti al verbo, lasciando la preposizione inalterata: προσέβαλλον.
Questo spiega perché nei testi più antichi (soprattutto in Omero) si trovano frequentemente esempi di aumento proclitico posto davanti all’intero composto, mentre nei testi della prosa classica diventa normale l’aumento davanti alla radice verbale
L’uso omerico e la flessibilità arcaica
Nell’epica arcaica, e in particolare in Omero, l’aumento è spesso facoltativo e la sua posizione varia con grande libertà. Si possono trovare esempi come ἐπεβάλετο ma anche προσέβαλε. In certi casi, l’aumento manca del tutto, segno che nell’epoca omerica non era ancora percepito come obbligatorio.
Questa libertà riflette la fase in cui l’aumento non era ancora un elemento strettamente grammaticalizzato, ma piuttosto un segno temporale facoltativo, usato quando il poeta voleva evidenziare l’azione passata. Non a caso, nei verbi composti l’aumento iniziale davanti a tutta la parola poteva servire anche da risorsa metrica, permettendo una sillaba in più per l’esametro.
L’età classica e la regolarizzazione dell’uso
Con il V secolo a.C. e la fissazione della prosa attica, l’uso dell’aumento nei composti si stabilizza. L’aumento tende quasi sempre a porsi dopo la preposizione, quindi davanti al verbo vero e proprio. Ecco perché in testi come quelli di Tucidide, Senofonte o Platone si trovano sistematicamente forme come προσέβαλλον, κατέλυον, ἀπέστειλα.
Questo fenomeno testimonia che ormai la preposizione non è più sentita come autonoma, ma come parte integrante del verbo. Il legame morfologico è diventato indissolubile, e il greco classico ha cristallizzato questa fusione. L’aumento proclitico davanti a tutta la parola sopravvive solo in casi eccezionali o per ragioni stilistiche.
Il greco ellenistico e la Koiné
Con l’avvento della Koiné ellenistica, l’aumento comincia a perdere forza. Già nei papiri del periodo alessandrino e poi nel Nuovo Testamento si trovano sempre più spesso forme senza aumento, segno di una tendenza alla semplificazione del sistema verbale. Nei composti, la forma più comune rimane quella con l’aumento davanti al verbo, come in προσέβαλον, ma la sua presenza diventa progressivamente meno regolare.
Questa evoluzione continua nel greco bizantino e moderno, dove l’aumento sopravvive solo in alcune forme fossilizzate o in contesti letterari arcaizzanti.
Regola generale
Come attesta Il nuovo greco di Campanini:
- Nei verbi composti con una o più preposizioni l’aumento si colloca tra le preposizioni e il tema verbale:
- εἰσβαίνω (imbarcarsi) → tema + aumento = εἰσεβαιν-
- προεισφέρω (pagare in anticipo) → tema + aumento = προεισεφέρ-
- Le preposizioni che terminano in vocale elidono la vocale finale davanti all’aumento:
- ἀποβαίνω (scendere) → tema + aumento = ἀπεβαίν-
- Fanno eccezione a questo proposito περί e ἀμπφί, che conservano la vocale:
- περιβαίνω (avanzare) → tema + aumento = περιεβαιν-
- ἀμφιβάλλω (cingere) → tema + aumento = ἀμφιεβαλλ-
- La vocale finale di πρό talvolta si conserva, talvolta dà luogo a crasi con l’aumento (προὐ-):
- προβαίνω (avanzare) → tema + aumento = προεβαίν-/προὐβαίν-
- Fanno eccezione a questo proposito περί e ἀμπφί, che conservano la vocale:
- ἀποβαίνω (scendere) → tema + aumento = ἀπεβαίν-
- Le preposizioni che escono in consonante riprendono la loro forma originaria, se questa si è alterata nella formazione del composto. In particolare, questo avviene con le preposizioni σύν ed ἐν:
- ἐγγάφω (inscrivere) → tema + aumentato = ἐνεγραφ-
- ἐμμένω (rimanere) → tema + aumento = ἐνεμεν-
- συλλαμβάνω (raccogliere) → tema + aumentato = συνελαμβαν-
- συμβαινω (accadere) → tema + aumento = συνεβαιν-
- La preposizione ἐκ davanti all’aumento assume la forma ἐξ:
- ἐκβαινω (uscire) → tema + aumento = ἐξεβαιν-
- La preposizione ἐκ davanti all’aumento assume la forma ἐξ:
- I composti con δυσ- presentano:
- l’aumento prima di δυσ- se il tema verbale inizia per vocale lunga o consonante:
- δυσφορέω (mal sopportare) → tema + aumento = ἐδυσφορ-
- l’aumento dopo di δυσ- se il tema verbale inizia per vocale breve:
- δυσελπίζω (disperare) → tema + aumento = δυσηλπιζ-
- l’aumento prima di δυσ- se il tema verbale inizia per vocale lunga o consonante:
- Nei composti con εὐ- è possibile trovare l’aumento sulla vocale iniziale del tema verbale soltanto quando essa è breve; altrimenti, l’aumento o manca del tutto o cade sul prefisso:
- εὐεργετέω (fare bel bene) → εὐεργετε-/εὐηργετε-
- εὐλαβέομαι (stare in guardia) → εὐλαβε-; ηὐλαβε-

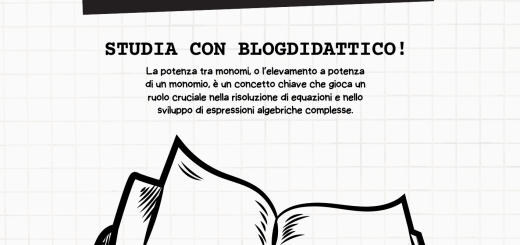
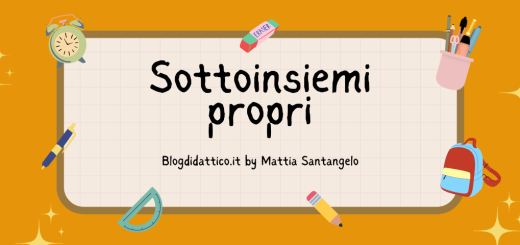

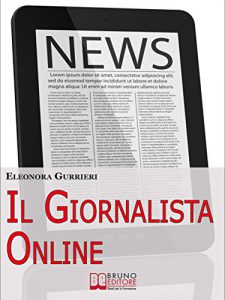
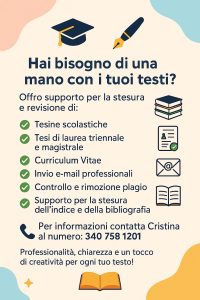


Una risposta
[…] complesso e affascinante sistema verbale del greco antico, l’infinito occupa un posto di rilievo per la sua straordinaria flessibilità […]