Declinazione dei sostantivi maschili e femminili della seconda declinazione del greco antico
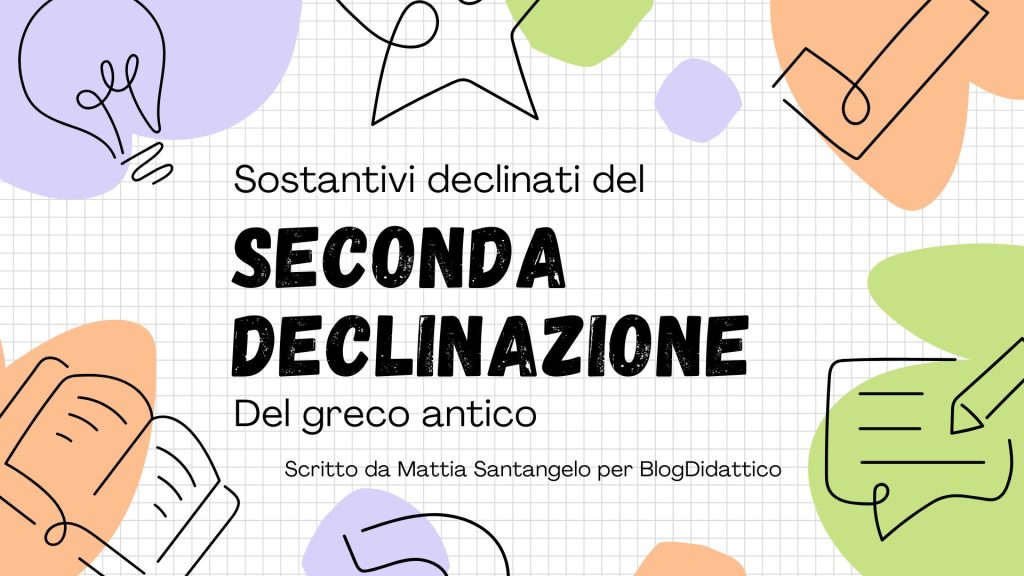
Come già precedentemente accennato all’interno dell’articolo riservato ai Caratteri generali della seconda declinazione, nel ricchissimo sistema morfologico dell’antico greco, la declinazione dei sostantivi, suddivisa in tre grandi gruppi, ricopre un ruolo fondamentale nell’espressione delle relazioni grammaticali tra le parole. Oltre alla prima declinazione, trattata già negli articoli precedenti, si ricorda anche la seconda, contenete sostantivi maschili, femminili e, in più alla prima, anche i neutri, ossia tutti coloro che per i greci non erano genericamente identificabili, come tutti i nomi degli oggetti.
All’interno di quest’articolo ci soffermeremo principalmente sulla declinazione dei sostantivi maschili e femminili della seconda declinazione, spiegando i neutri nel post venturo, riportando anche curiosità e osservazioni importanti.
Declinazione sostantivi maschili e femminili
| Numero | Caso | λόγος “discorso” (sostantivo maschile) | ἤπειρος “continente” (sostantivo femminile) |
|---|---|---|---|
| Singolare | Nominativo | ὁ λόγος | ἡ ἤπειρος |
| Singolare | Genitivo | τοῦ λόγου | τῆς ἠπείρου |
| Singolare | Dativo | τῷ λόγῳ | τῇ ἠπείρῳ |
| Singolare | Accusativo | τὸν λόγον | τὴν ἤπειρον |
| Singolare | Vocativo | ὦ λόγε | ὦ ἤπειρε |
| Duale | Casi diretti | τώ λόγω | τὼ ἠπείρω |
| Duale | Casi obliqui | τοῖν λόγοιν | τοῖν ἠπείροιν |
| Plurale | Nominativo | οἱ λόγοι | αἱ ἤπειροι |
| Plurale | Genitivo | τῶν λόγων | τῶν ἠπείρων |
| Plurale | Dativo | τοῖς λόγοις | ταῖς ἠπείροις |
| Plurale | Accusativo | τοὺς λόγους | τὰς ἠπείρους |
| Plurale | Vocativo | ὦ λόγοι | ὦ ἤπειροι |
Osservazioni
- La declinazione dei femminili e quella dei maschili coincidono in tutti i casi a differenza dei neutri che presentano uscite diverse per i casi diretti del singolare e del plurale;
- Ai fini dell’accentazione, vale la norma generale in base alla quale l’accento tende a conservare la posizione e la natura che presenta la nominativo, almeno finché lo consentono le leggi generali che ne governano l’uso. Tuttavia, anche in questo caso, come abbiamo già osservato a proposito della prima declinazione, i sostantivi ossitoni al nominativo diventano perispomeni nei casi obliqui.
Nella seconda declinazione abbiamo quindi vari sostantivi:- parossitoni (λύκος): l’accento si mantiene sempre sulla penultima sillaba;
- proparossitoni (ἄνθρωπος): l’accento è sempre acuto ma si sposta quando la desinenza è breve;
- ossitoni (ποταμός): l’accento acuto si modifica in circonflesso nei casi obliqui;
- properispomeni (νῆσος): l’accento è sempre sulla penultima sillaba del sostantivo ma è circonflesso quando l’ultima sillaba è breve, e si modifica in acuto quando l’ultima è lunga;
- perispomeni (δῶρον): molto rari, ma esistono comunque. Presentano l’accento circonflesso per tutta la declinazione.
- Il vocativo singolare in -ε, sentito come un arcaismo, come afferma il libro Il nuovo greco di Campanini, ha subito la concorrenza del nominativo, adoperato con funzione di vocativo già in Omero, dove, per esempio, troviamo ὦ φίλος accanto a ὦ φίλε “o amico!”. In attico, peraltro, manca una forma specifica di vocativo per θεός “dio”, che si presenta uguale al nominativo (come accade del resto al latino deus); θεέ è attestato solamente nel greco postclassico, a partire dal Nuovo Testamento. I composti, invece, si comportano regolarmente: per esempio Τιμόθεος presenta al vocativo la forma Τιμόθεε;
- Il sostantivo ἀδελφός “fratello” al vocativo singolare ritrae l’accento: ὦ ἄδελφε.
- L’uscita -οι del nominativo e del vocativo plurale, benché prosodicamente lunga, è considerata breve ai fini dell’accento.

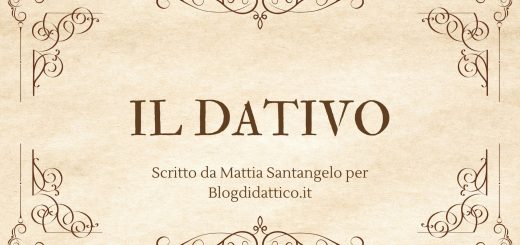

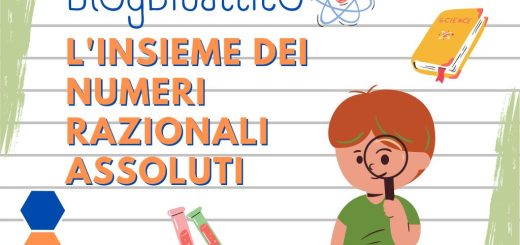
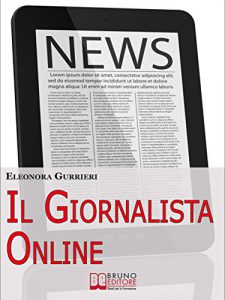
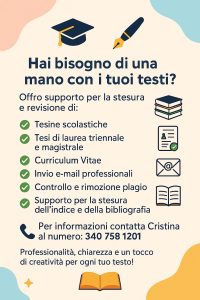


Una risposta
[…] lingua greca antica, l’infinito è una forma verbale estremamente duttile, in grado di assumere molteplici funzioni […]