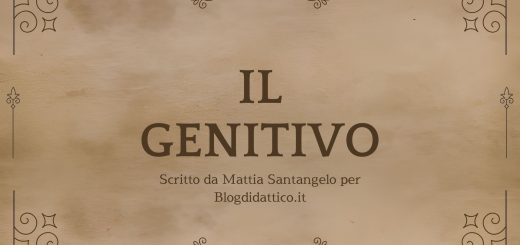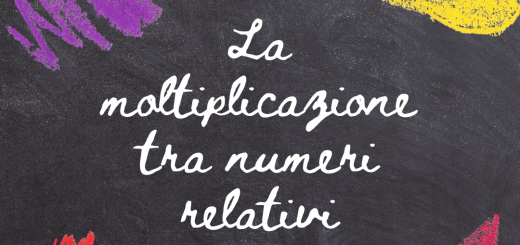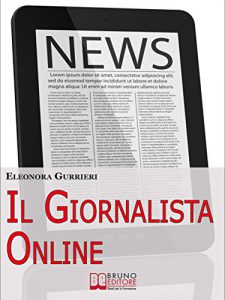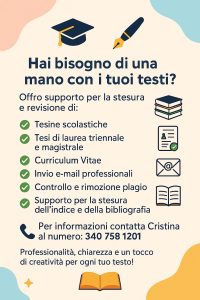La declinazione attica della seconda declinazione
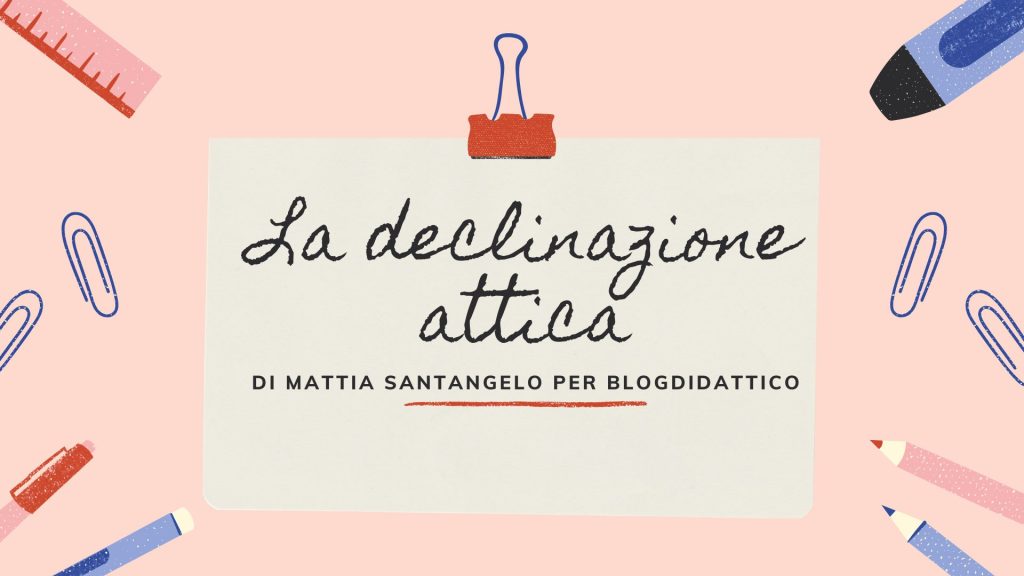
Finora, all’interno del nostro blog, abbiamo trattato la seconda declinazione secondo il modello classico standard. Tuttavia, è importante ricordare che l’antico Grecia non era linguisticamente uniforme, bensì un vero e proprio mosaico di versioni dialettali. Proprio per questo motivo, nelle nostre traduzioni ci imbattiamo spesso in forme dialettali, tra cui spicca per rilevanza e diffusione quella attica. Comprendere a fondo la declinazione attica non è solo utile, ma essenziale per affrontare con consapevolezza i testi letterari, filosofici e storici scritti in questo prestigioso dialetto.
Definizione
Con il termine “declinazione attica” non si intende una declinazione separata dalle tradizionali prima, seconda e terza declinazione del greco antico, bensì una variante linguistica specifica del dialetto attico, cioè il dialetto parlato in Atene durante il V-IV secolo a.C., che diventò poi la base del greco classico e dell’alfabetizzazione panellenica.
Nel tempo, l’attico fu:
- Il dialetto di Sofocle, Euripide, Aristofane, Platone, Demostene;
- La base della koinè, cioè la lingua comune dell’ellenismo;
- Un modello di raffinatezza e purezza stilistica in ambito letterario.
Quando parliamo di “declinazione attica”, dunque, ci riferiamo a forme morfologiche (cioè desinenze e varianti flessive) specifiche dell’attico all’interno delle declinazioni canoniche.
Declinazione attica
| Numero | Caso | νεώς “dono” |
|---|---|---|
| Singolare | Nominativo | νεώς |
| Singolare | Genitivo | νεώ |
| Singolare | Dativo | νεῴ |
| Singolare | Accusativo | νεών (νεώ) |
| Singolare | Vocativo | νεώς |
| Duale | Casi diretti | νεώ |
| Duale | Casi obliqui | νεῴν |
| Plurale | Nominativo | νεῴ |
| Plurale | Genitivo | νεών |
| Plurale | Dativo | νεῴς |
| Plurale | Accusativo | νεώς |
| Plurale | Vocativo | νεώ |
Osservazioni
- La ω del tema, come afferma il libro Il Nuovo Greco di Campanini, può essere originaria (λαγώς “lepre”; κάλως “gomena”) o derivare da metatesi quantitativa in sostantivi originariamente uscenti in -ηο (νηός → νεώς);
- Ai fini dell’accentazione è facilmente considerabile:
- l’accento rimane in tutti i casi sulla sillaba su cui si trova al nominativo (sostantivi come Μενέλεως “Menelao” sono parossitoni, dal momento che il gruppo εω costituisce un’unica sillaba per sinizesi);
- gli ossitoni conservano l’accento acuto anche nei casi obliqui.